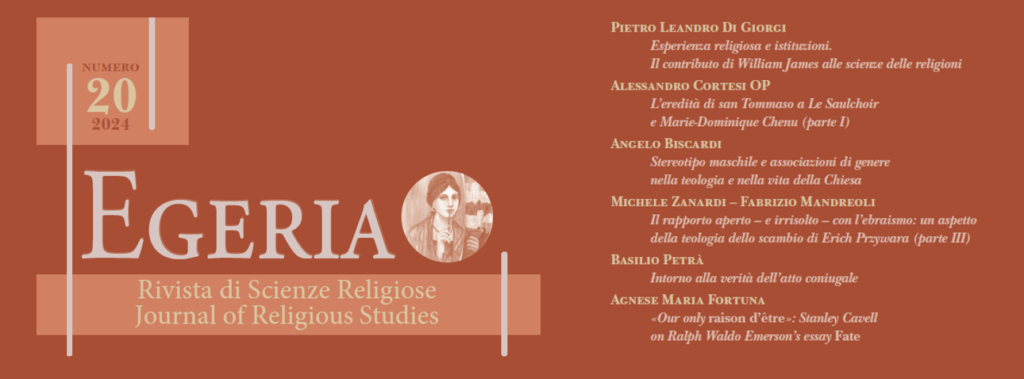
Angelo Biscardi
STEREOTIPO MASCHILE E ASSOCIAZIONI DI GENERE NELLA TEOLOGIA E NELLA VITA DELLA CHIESA
Lo stereotipo del maschile ha plasmato l’immaginario cristiano e cattolico nel
corso del tempo, influenzando diverse dimensioni dell’esperienza credente.
Gli studi di genere attuali consentono di individuare e valutare la presenza di elementi
stereotipanti rispetto all’immagine di Dio, alle assegnazioni simboliche che
si agganciano alla corporeità maschile e femminile, e ai ruoli sociali ed ecclesiali.
La teologia, da parte sua, sta crescendo nel riconoscimento di come il vangelo
debba produrre una riflessione critica sulle dinamiche di subordinazione che
possono scaturire da una lettura parziale del testo biblico e dalle elaborazioni del
significato della differenza sessuale.
The stereotype of the masculine has shaped the Christian and Catholic imaginary over
time, influencing a lot of dimensions of the believing experience.
Current gender studies make it possible to identify and assess the presence of stereotypical
elements with respect to the image of God, symbolic assignments linked to male
and female corporeality, and social and ecclesiastical roles.
Theology, for its part, is improving in realizing how the gospel should produce a critical
reflection with respect to the dynamics of subordination that can arise from a
partial reading of the biblical text and from contemporary elaborations of the meaning
of sexual difference.
Alessandro Cortesi OP
L’EREDITÀ DI SAN TOMMASO A LE SAULCHOIR E MARIE-DOMINIQUE CHENU
Parte I
Questo articolo intende offrire uno studio sulle fasi di formazione della teologia
di Marie-Dominique Chenu, in particolare nel suo approccio storico a san Tommaso.
Una presentazione introduttiva sul contesto storico e teologico tra XIX e
XX secolo è seguita da una descrizione degli orientamenti e dei metodi di studio
a Le Saulchoir. Ambroise Gardeil OP è stato il principale promotore di quella
casa di studi domenicana con molti altri contributi. In questo contesto, Chenu
ha sviluppato una lettura personale di Tommaso d’Aquino con l’applicazione del
metodo storico.
This article aims to offer a study of the formation phases of Marie-Dominique Chenu’s
theology, particularly in his historical approach to St Thomas. An introductory presentation
on the historical and theological context between the 19th and 20th centuries
is followed by a description of the orientations and methods of study at Le Saulchoir.
Ambroise Gardeil OP was the main promoter of that dominican house of study with
many other contributions. In that context, Chenu developed a personal reading of
Thomas Aquinas with the application of the historical method.
Pietro Leandro Di Giorgi
ESPERIENZA RELIGIOSA E ISTITUZIONI.
IL CONTRIBUTO DI WILLIAM JAMES ALLE SCIENZE DELLE RELIGIONI
Nel classico libro di James, The Varieties of Religious Experience, fondato sull’analisi
psicologica del sentimento religioso, si può trovare anche un approccio sociologico
alle istituzioni ecclesiastiche e alle loro relazioni conflittuali con la forza
rivoluzionaria dei carismatici religiosi. La descrizione jamesiana dei molteplici
modi di attingere il divino, che rigenerano le energie spirituali e permettono di
cogliere «l’anima onnicomprensiva del mondo», è ancora molto utile per interpretare
le forme deboli del religioso post-secolare, che si ripromettono, con modalità
proprie di uno spiritualismo olistico, l’obiettivo di una trascendenza immanente
e di una de-verticalizzazione dell’esistenza.
In the classic James’ The Varieties of Religious Experience, with its psychological
analysis of religious emotions, we find also a sociological approach to ecclesiastical
institutions and their conflictual relations with religious charismatic leaders. James’
description of many ways to perceive the divinity, which enforce spiritual energies and
allow to grasp «the absolute soul of world», is still very useful to understand post-secular
low intensity religion, whose holistic spiritualism wants to reach immanent transcendency
and de-verticalization of life.
Agnese Maria Fortuna
«OUR ONLY RAISON D’ÊTRE»: STANLEY CAVELL ON RALPH WALDO EMERSON’S ESSAY FATE
Il perfezionismo di Ralph Waldo Emerson viene solitamente collegato a testi come TheAmerican Scholar (1837) e Self-Reliance (1841) in modo da evidenziarlo come un racconto ottimista delle capacità umane di autoespressione e miglioramento, basate sull'autonomia e il virtuosismo individuali. In questa luce, altri testi come Nature (1836) sono considerati solo nelle loro dichiarazioni ottimistiche, ma sottovalutano lo scetticismo dilagante di Emerson: Experience (1844) diventa una sorta di episodio parentetico di scoraggiamento e Fate (1860-1879) il distillato estremo della conversione finale di Emerson del suo idealismo romantico in un'opera di rigore.
Ralph Waldo Emerson’s perfectionism is usually connected with texts such as The
American Scholar (1837) and Self-Reliance (1841) in a way that stresses it as an optimist
account of the human capabilities of self-expression and improvement grounded on individual
autonomy and virtuosity. In this light, other texts such as Nature (1836) are considered
only in their optimistic declarations underestimating Emerson’s spreading skepticism,
Experience (1844) becomes a kind of parenthetical episode of discouragement, and Fate
(1860-1879) the extreme distillate of Emerson’s final conversion of his Romantic idealism
into stark.
Basilio Petrà
INTORNO ALLA VERITÀ DELL’ATTO CONIUGALE
L’articolo studia l’evoluzione recente del magistero cattolico riguardo al rapporto
tra atto coniugale (nel linguaggio cattolico sinonimo di «unione sessuale») e amore
coniugale, partendo dalla visione del Codex iuris canonici all’inizio del Novecento
per giungere fino ad Amoris laetitia (2016), passando attraverso l’esame di alcuni
testi del concilio Vaticano II e della loro influenza sul Codice di diritto canonico,
l’analisi dell’Humanae vitae e della Familiaris consortio. Al termine di tale percorso
appare possibile affermare che l’atto coniugale è vero quando esprime attraverso
il linguaggio del corpo la forma coniugale dell’amore, una forma dell’amore che
può darsi esistenzialmente (sul piano dell’esistenza) in contesti diversi, siano essi
giuridicamente sanzionati o no.
The article studies the recent evolution of the Catholic Magisterium regarding the
relationship between the conjugal act (in Catholic parlance synonymous with «sexual
union») and conjugal love, starting from the vision of the Codex iuris canonici at
the beginning of the 1900s and ending with Amoris laetitia (2016), passing through
the examination of some texts of the Second Vatican Council and their influence on
the Code of Canon Law, the analysis of Humanae vitae and Familiaris consortio.
At the end of this journey, it appears possible to affirm that the conjugal act is true
when it expresses through the language of the body the conjugal form of love, a form
of love that can give itself existentially (on the plane of existence) in different contexts, whether legally sanctioned or not.
Michele Zanardi – Fabrizio Mandreoli
IL RAPPORTO APERTO – E IRRISOLTO – CON L’EBRAISMO: UN ASPETTO DELLA TEOLOGIA DELLO SCAMBIO DI ERICH PRZYWARA
Parte III
In questo terzo contributo su una delle opere più tarde – Commercium – del
filosofo e teologo Erich Przywara gli autori si concentrano sulla conclusione che
cita come chiave di lettura dell’intera ricostruzione della storia della salvezza – e
del rapporto tra teologia e filosofia – alcuni versetti di Romani 11. Il lavoro cerca
quindi di capire, in due tappe, le ragioni di tale citazione strategica. Nella prima
si ricostruisce il background della sua riflessione tramite alcuni aspetti del metodo
di Przywara, dei suoi interessi teologico-politici, del rapporto con il pensiero e gli
autori ebraici a lui contemporanei. In una seconda tappa si cerca il contesto più
immediato del suo modo di intendere la Lettera ai Romani e il ruolo di Israele
nella storia della salvezza intesa in senso cristiano tramite il commento ad alcune
pagine dell’opera fondamentale, ma non priva di questioni, Alter und Neuer
Bund. Al termine, a partire dalla conclusione dell’opera Commercium si individuano
alcune direttrici di fondo del contributo teologico e filosofico dell’autore
che aprono a ulteriori questioni rilevanti, in particolare l’emersione – allora come
oggi – del tema messianico.
In this – third – contribution on one of the later works, Commercium, by the philosopher
and theologian Erich Przywara, the authors focus on the conclusion that cites
verses from Romans 11 as the key to his entire reconstruction of salvation history. The
paper then seeks to understand, in two stages, the reasons for such a strategic citation.
In the first, the background of his vision is reconstructed through three highlights: some
aspects of Przywara’s method, his theological-political interests, and his relationship
with Jewish thought and authors contemporary with him.
In a second stage, the more immediate context of his theology and philosophy in Commercium
is studied focusing on his understanding of the letter to the Romans and the role of Israel in salvation history and on some pages of the seminal and not-unproblematic
work Alter und Neuer Bund. At the end, the authors identify some basic directions
of the author’s theological and philosophical contribution that open to further
relevant questions, in particular the emergence – then as now – of the messianic theme.
